Educazione civica ed educazione alla pace: un confronto
1) un approccio olistico nell’affrontare le problematiche, che vede i diversi aspetti del mondo e delle varie discipline mai in contrapposizione gli uni agli altri, o come comparti separati, bensì strettamente correlati tra loro e quindi interdipendenti, nell’ambito di una prospettiva globale, dove ogni dettaglio, ogni fenomeno acquisisce un suo significato in quanto parte di un tutto; si pensi per esempio ai progetti di educazione ambientale o di educazione alla sostenibilità;
2) il perseguimento di obiettivi trasversali, che investono più discipline, proprio perché connessi alla formazione della persona nel suo complesso, con competenze di base applicabili in situazioni e ambiti diversi.
Anche queste iniziative di innovazione disciplinare hanno avuto delle conseguenze sul piano linguistico; per il loro modo nuovo, alternativo, di guardare ai problemi dell’umanità, esse hanno generato nuovi concetti e quindi nuovi termini, che si sono affermati e consolidati nelle varie lingue nel corso degli anni successivi fino ad oggi.
Parole come globalizzazione e globalità non sono ancora riportate nei dizionari degli anni ’70 e primi anni ‘80; altri termini hanno solo in tempi recenti ampliato il loro campo semantico, come per esempio sostenibilità, che nei dizionari di circa trenta anni fa viene riportato esclusivamente correlato al significato materiale del verbo sostenere.
Sia l’educazione civica che l’educazione alla pace includono queste tematiche nella propria area di competenza; si verifica pertanto un punto di contatto e di sovrapposizione tra le due discipline, che si intende qui di seguito approfondire.
L’educazione alla pace nasce verso la metà del XIX secolo. Si è evoluta sia dal punto di vista teorico, come disciplina che si prefigge un modo alternativo di pensare il mondo, contrapposto alla cultura imperante della violenza e della guerra, sia come scienza preposta alla trasmissione di competenze e abilità, quindi su un piano pedagogico e pratico-operativo, con cui contrastare modelli di vita violenti tramite strategie di prevenzione e soluzione pacifica dei conflitti, nel rispetto dei diritti umani fondamentali, dell’ambiente, della diversità. Si tratta di obiettivi a lungo termine, che l’educazione alla pace persegue con finalità politiche, per trasformare la società e la mentalità, rivelandone gli aspetti violenti, spesso non riconosciuti come tali nella coscienza collettiva.

Nel corso degli ultimi decenni settori disciplinari come l’educazione ambientale, l’educazione alla cittadinanza globale, alla sostenibilità, alla legalità, all’interculturalità, alle differenze di genere e altri simili ambiti sono stati spesso consapevolmente presentati o comunque percepiti come legittimo complemento dell’educazione alla pace, anche perché la maggior parte degli autori delle numerose pubblicazioni recenti in merito si riconoscono come appartenenti alla cultura della pace. Si deve però fare presente che i testi di educazione civica non solo riportano questi stessi settori tra quelli di propria competenza, come già accennato sopra, ma molte volte vi includono anche l’educazione alla pace, che in tal
caso figura non come scienza autonoma ma solo come uno dei tanti aspetti da approfondire nella formazione del cittadino.
Dal secondo dopoguerra infatti l’educazione civica si è trasformata sempre più da “educazione allo Stato” a “educazione alla democrazia”: dai valori di patriottismo, fedeltà allo Stato e alle tradizioni locali e nazionali, che avevano costituito i cardini dell’educazione civica nei secoli precedenti, si è passati all’obiettivo della formazione del cittadino, per fornire a questi un bagaglio di conoscenze e competenze, che gli permettano di partecipare in modo libero e responsabile alla vita
democratica in tutti i suoi aspetti, di giudicare e operare scelte in modo autonomo; si è progressivamente affermato un concetto di democrazia fondato sul pluralismo sociale, sul lavoro, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri di ogni cittadino e delle libertà individuali, sul principio dell’uguaglianza, intesa sia in senso formale sia come parità di opportunità tra i cittadini e tra uomini e donne. In quest’ottica vivere nella democrazia significa anche confrontarsi con problemi come l’immigrazione e le differenze culturali, le minoranze e la loro tutela (intesa anche come tutela delle diversità), le disuguaglianze economico-sociali e la conseguente difficoltà di far valere il già citato principio delle “pari opportunità”, la necessità di sviluppare un dialogo fondato sulla tolleranza e sul rispetto reciproci. Si tratta quindi di acquisire una serie di comportamenti e valori condivisi che riguardano la persona in sé prima ancora del cittadino.
Già all’inizio degli anni ’60 il politologo Starnberger definiva la pace come il fondamento, la categoria più importante della politica; negli anni ‘70 Karl Friedrich Roth poneva esplicitamente il quesito se l’educazione alla pace non fosse ormai da considerare un nuovo compito dell’educazione civica; nello stesso anno 1970 la Bundeszentrale für Politische Bildung di Bonn pubblicava nel suo settimanale “Das Parlament” il contributo di Hans-Günther Assel, docente di scienze politiche, “Friedenspädagogik als Problem politischer Bildung”, la pedagogia della pace come problema dell’educazione civica.
La questione di tale ampliamento dell’educazione civica con un’apertura a temi che non fossero limitati alle istituzioni dello Stato e ai diritti e doveri dei cittadini, nacque in Germania, dove questa disciplina, che fu imposta ai tedeschi dagli Stati Uniti come programma di rieducazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, ebbe un’attenzione da parte del mondo accademico e un approfondimento che non ha riscontro negli altri Paesi europei.
Si ritiene pertanto che proprio questa evoluzione dell’educazione civica abbia portato a un sempre maggiore avvicinamento della stessa all’educazione alla pace, fino ad una sovrapposizione di competenze, che oggi può in certi contesti rendere difficile distinguere le due discipline.
Articoli correlati
 Coltivare memoria, pace e futuro
Coltivare memoria, pace e futuroIl progetto "Kaki Tree for Europe"
Tutto nasce dalla straordinaria storia dell'albero di kaki di Nagasaki. Sopravvissuto miracolosamente al bombardamento atomico del 9 agosto 1945, questo albero è diventato, nel mondo, un simbolo vivente di resilienza, memoria e speranza.29 aprile 2025 - Alessandro Marescotti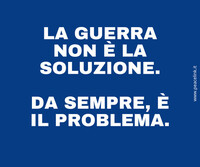 Intervento di Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink
Intervento di Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLinkEducare al pensiero critico per educare alla pace
Incontro di informazione, riflessione e dibattito, 13 aprile 2025, via di Caciolle 7, Firenze organizzato dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle Università.13 aprile 2025 - Redazione PeaceLink Storia di un percorso e di un approdo per un viaggio appena cominciato
Storia di un percorso e di un approdo per un viaggio appena cominciato“Una panchina per la Pace" a Foggia
Le panchine nei pressi delle scuole sono il luogo in cui i ragazzi e le ragazze amano sostare, incontrarsi, chiacchierare, raccontarsi. Quella esperienza di pace può essere coltivata con amore e può prendere il posto dell'atteggiamento guerresco per diventare una bussola dell’agire umano.8 aprile 2025 - Antonietta Lelario e Donata Glori Gruppo MCE Educazione alla Pace e alla Nonviolenza
Gruppo MCE Educazione alla Pace e alla NonviolenzaInsegnanti per la pace: un percorso di educazione alla nonviolenza
È stato lanciato un appello a tutti coloro che desiderano contribuire a costruire percorsi di educazione alla pace. Chiunque sia interessato a partecipare al progetto può iscriversi entro il 26 novembre e partecipare al primo incontro online il 28 novembre.18 novembre 2024 - Redazione PeaceLink
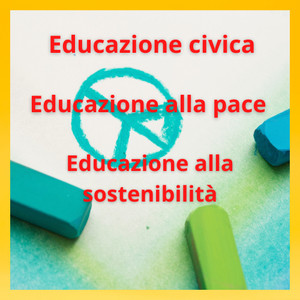
Sociale.network