I limiti del progresso
All’incirca 1,5 milioni di anni fa, da qualche parte nell’Africa meridionale, un Homo erectus imparò a controllare il fuoco. Senza di esso oggi non bruceremmo né carbone né petrolio, non accenderemmo il riscaldamento e non griglieremmo la carne. Quest’ultima, se viene cotta, è più sana di quella mangiata cruda e il fuoco consente di cucinare piante altrimenti indigeribili, tiene lontani gli animali ed emana calore.
Gli uomini vissero più a lungo, accrebbero la loro intelligenza e inventarono la medicina. Addomesticarono gli animali per farne bestiame da allevamento, forgiarono aratri, costruirono miniere di carbone, svilupparono la produzione di acciaio, incenerirono intere foreste, inventarono le automobili, il lavoro notturno e il capitalismo globale. Tutto in nome del progresso.
Se l’Homo erectus avesse saputo in che situazione ci saremmo cacciati per via del suo fuoco, forse ci avrebbe ripensato.
No, non lo avrebbe fatto. Perché il progresso è una droga. E una droga accelera il battito cardiaco, induce euforia, espande la coscienza e richiede un effetto sempre più incisivo e durevole. All’inizio del XXI secolo siamo arrivati al punto in cui gli effetti stanno via via affievolendosi. Nella sua fase discendente l’ebbrezza spesso comporta fiacchezza, sconforto e perfino ansia, senso di colpa e autorecriminazione. Alcuni di quanti si battono contro la crisi climatica affermano di essere esausti.
Sfruttamento progressivo
Dall’inizio della Rivoluzione industriale nelle miniere di carbone in Inghilterra alla sostituzione della carrozza con l’automobile fino alla globalizzazione del mondo delle merci - compresa la merce turista - all’inizio del XXI secolo, il progresso è stato inscindibilmente legato allo sfruttamento delle fonti fossili e a una sempre crescente domanda di energia.
Anche le innovazioni nel campo dei computer quantistici e dell’intelligenza artificiale sono anzitutto questo: divoratori di energia. Progresso significa progressivo sfruttamento delle risorse naturali. È una finalità della specie umana che la differenzia da tutte le altre forme di vita presenti sulla terra. Piante e animali non sono in grado di distruggere i propri mezzi di sussistenza.
Secondo il vocabolario Oxford languages, «progresso» significa «evoluzione positiva, raggiungimento di un livello più elevato di sviluppo». L’Inghilterra è spesso definita «la patria della democrazia». La Gloriosa rivoluzione ebbe luogo un secolo prima della Rivoluzione francese e la moderna separazione dei poteri risale all’Illuminismo inglese. La dissoluzione dello Stato feudale e lo sviluppo della democrazia sono stati il principale avanzamento sociale della modernità. La Riforma e l’Illuminismo sono i punti di partenza di un’evoluzione che ha dato a una larga fetta dell’umanità lo Stato di diritto, i diritti umani e, ad alcuni, finanche un’educazione antiautoritaria.
Il progresso tecnico e l’industrializzazione garantiscono sufficienti quantità di cibo e l’avanzamento della benefica medicina moderna e incentivano il dinamismo economico e una ricchezza (perlomeno per una parte dell’umanità) inimmaginabile 1,5 milioni di anni fa. All’inizio del XXI secolo, gli uomini devono decidere se riescono a scindere il progresso dal fuoco.
Oltre che per l’uscita dai combustibili fossili, l’emergenza climatica non ci lascia, per usare un’espressione dell’ex cancelliera Angela Merkel, «altra scelta». Un’evoluzione positiva e il raggiungimento di un livello più elevato - il progresso - dovrebbero perciò essere uno sviluppo che protegge i mezzi di sussistenza disponibili sul pianeta e salvaguarda nel contempo la democrazia, la medicina moderna e una bastevole quantità di cibo e di ricchezza (per il numero maggiore possibile di persone).
Individui potenziati
Nel 2023 non si può scrivere di progresso senza citare Yuval Noah Harari. Alla narrazione positiva dell’innovazione, lo storico e filosofo israeliano aggiunge un’altra considerazione, non meno inaccettabile: il progresso, in poche parole, significa incremento di efficienza, non necessariamente felicità. C’era già arrivato Karl Marx. L’efficienza divide le persone in povere e ricche. Ciò ha un senso, poiché chi controlla il fuoco, è fuor di dubbio che controlli anche i suoi simili.
La teoria del progresso di Harari nel XXI secolo si traduce nella suddivisione dell’umanità tra una specie di individui potenziati con procedure bioingegneristiche o alla stregua di cyborg e il resto lasciato indietro. Nel marzo del 2023 Harari ha aderito alla richiesta di oltre mille esperti del mondo della tecnologia, della ricerca e della scienza di istituire una moratoria di sei mesi sull’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale «più potenti di GPT-4».
Il progresso è una droga. La cui inebriante scia pare stia circolando nei laboratori di ricerca sullo sviluppo dell’IA. Il ritmo con cui creano programmi sempre più performanti supera di gran lunga la velocità di adattamento delle società democratiche. Dopo che l’IA conversazionale ChatGPT e strumenti concorrenti sono stati resi fruibili all’appendice di internet, l’essere umano, i timori ci assalgono. L’idea che quest’intelligenza artificiale possa autonomizzarsi dal controllo dell’uomo e superare l’Homo sapiens sulla strada dell’evoluzione spinge alcuni modelli a impulsi straordinari.
Anche pionieri dell’innovazione quali Elon Musk e Steve Wozniak hanno sottoscritto la lettera per la moratoria. Il progresso divora i suoi figli. E l’Unesco, in risposta, chiede agli Stati della comunità internazionale di tradurre le raccomandazioni sull’impiego etico dell’IA in normative nazionali.
Limitare funziona?
Il padre delle bombe atomiche fatte detonare nei cieli di Hiroshima (Little Boy) e Nagasaki (Fat Man) durante il secondo conflitto mondiale, nonché direttore scientifico del cosiddetto progetto Manhattan, fu Robert Oppenheimer. Dopo aver sperimentato l’impatto dell’arma sviluppata sotto la sua direzione, la sua portata devastatrice in termini di perdite di vite umane, Oppenheimer pare abbia detto al presidente Truman di sentire le mani sporche di sangue. Ciò valeva per lui quanto per i suoi colleghi dell’accampamento nel quale erano state costruite le bombe. Tuttavia, mentre Oppenheimer decise di opporsi alla ricerca sulle armi nucleari, i suoi collaboratori scientifici continuarono a indagare. Quest’innovazione andava fermata nello stesso istante in cui l’arma più infernale mai creata dall’uomo apparve sopra Hiroshima sotto forma di un fungo atomico. Ma controllare, frenare il progresso ha mai funzionato? All’inizio del XXI secolo, gli uomini devono anche decidere se possono porvi dei limiti.
Né le limitazioni agli avanzamenti tecnologici né l’uscita dal fossile sono in contraddizione col progresso. Senza il costante sviluppo di tecnologie per ricavare energia a impatto zero e ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera, la lotta alla crisi climatica fallirebbe. Tra chi ripone le sue speranze nell’intelligenza artificiale, c’è anche e soprattutto la medicina: l’elaborazione di enormi quantità di dati permette miglioramenti non ancora prevedibili della diagnosi, della cura e della ricerca. In discussione non c’è il progresso in sé, ma la questione se vada interpretato solo nello spirito del motto olimpico «Più veloce, più in alto, più lontano» (o della sua versione valida dal 2020 «Più veloce, più in alto, più forte - insieme»).
Il visionario Lafontaine
Nel 1985 Oskar Lafontaine, ex esponente della Spd e più tardi di Die Linke, scrisse un libro intitolato Der andere Fortschritt («L’altro progresso»). In esso sosteneva la tesi secondo cui l’economia può consentire una vita soddisfacente anche senza crescita. «Il progresso tecnico soltanto in parte è un processo sempre positivo», notava Lafontaine. Secondo il suo parere, la società industriale era arrivata al limite. Sebbene economia, scienza e tecnica abbiano raggiunto straordinarie conquiste nei Paesi industrializzati, queste non compensano la distruzione arrecata e le minacce alla vita generate: disoccupazione di massa e povertà, morte per fame e da radiazioni atomiche, disastri ambientali e disagio sociale.
All’epoca la visione di Lafontaine non riuscì a imporsi. Sembrava precorrere i tempi. Oggi la studiosa di transizioni politiche Maja Göpel si rifiuta di equiparare il progresso alla crescita dell’analisi economica. È dell’avviso che il mito della costante crescita economica come principio alla base del progresso produca soprattutto una cosa: disuguaglianza e una vita al di sopra delle nostre possibilità umane. Con ciò, però, mette in discussione anche la costante del capitalismo, che stando al pensiero di Marx ha come presupposti la crescita e la massimizzazione del profitto.
A sostegno dell’idea che il capitalismo possa sopravvivere entro i limiti dettati dalle risorse naturali non esiste ancora alcuna prova. Il Club di Roma nel 1972 scelse il titolo «I limiti della crescita». Cinquant’anni dopo al centro del dibattito ci sono i limiti del progresso.
Articoli correlati
 Le trappole dell'Intelligenza Artificiale
Le trappole dell'Intelligenza ArtificialeSarebbe una fake new la lettera del Presidente del Burkina Faso Traoré a Papa Leone XIV
Circola un video in cui il presidente Traoré pronuncia un duro discorso anticolonialista. Utilizzando una funzione di "deep research" dell'Intelligenza Artificiale siamo riusciti a verificarne la veridicità e a scoprire che sarebbe una fake new forse generata con l'Intelligenza Artificiale stessa.18 maggio 2025 - Redazione PeaceLink Nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana
Nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umanaAntiqua et nova
In questo rapporto, redatto dai Dicasteri per la Dottrina della Fede e per la Cultura e l’Educazione, emerge l’urgenza di trattare l’IA non come un’entità autonoma, ma come un prodotto umano, da governare attraverso scelte collettive che rispettino l’etica, l’equità e la giustizia.28 gennaio 2025 - Redazione PeaceLink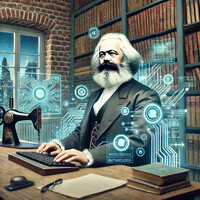 A coloro che interpretano il mondo invece di cambiarlo
A coloro che interpretano il mondo invece di cambiarloUn approccio quasi marxista all'Intelligenza Artificiale
Questi appunti, scritti in forma provocatoria, sono rivolti a tutti quelli che stanno alla finestra e fanno da spettatori nei confronti della più grande rivoluzione del nostro tempo. L'Intelligenza Artificiale la usano i cattivi mentre i buoni brontolano.28 dicembre 2024 - Alessandro Marescotti Che cosa del ragionamento umano non può essere implementato
Che cosa del ragionamento umano non può essere implementatoL’intelligenza artificiale come grande sfida
Una panoramica storica e filosofica per analizzare i limiti dell’Intelligenza Artificiale nel replicare pienamente la complessa capacità umana di generare approcci logici alternativi. Il saggio affronta anche le implicazioni etiche e politiche connesse all'ambito militare.23 dicembre 2024 - Antonino Drago
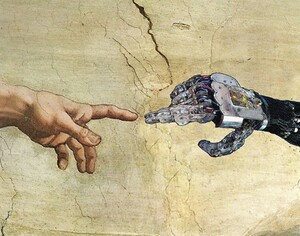
Per consultare il profilo completo del traduttore, cliccare qui:
www.linkedin.com/in/stefano-porreca
www.proz.com/profile/2546108