Dialogare, discutere, parlare e ricavare biografie da queste modalità comunicative e raccogliere la personale autobiografia, costituiscono un’antica forma culturale, consueta, di incoraggiamento e autoriconoscimento, svelando la natura pedagogica delle parole, quando, dai racconti, dalle storie, si impara sempre di sé, degli altri, del mondo, in eventi di pensiero.
Il pensiero è l’ambito profondo dei giochi discorsivi e conversazionali, rivolgendo le attività della mente a orizzonti, possibilità, sfide, in salti cognitivi, in variazioni di mentalità, nell’emergere di immagini diverse dalla realtà: narrare e far narrare costituiscono, innanzitutto, una tecnica visionaria, in un contesto quotidiano in cui troppo spesso si disperdono il senso e l’esperienza delle modalità narrative che rappresentano la storia di uomini e donne, la storia della trasmissione di sapere.
Nell’attuale crisi della narrazione e dell’oralità, si vive di suggestioni e immagini volte ad impressionare. La narrazione è una memoria in una trama da raccontare nelle intenzioni, negli scopi, nelle azioni dei protagonisti, nel significato di sequenze di storie, oltre gli stimoli, le impressioni, i segni chiusi in se stessi, suscitando emozioni, sviluppando interrogativi, pathos, enigmi, mistero.
La norma analogica della narrazione presenta un valore metaforico, simbolico, mitico. Il motivo logico è la morale nell’intrinseca pedagogia che insegna, consiglia, dimostra. Il metodo autobiografico ha capacità di promuovere desideri di conoscenza e trame di storie che sappiano educare e stupire.
Il senso biografico si evolve in antichi criteri narrativi dell’attività retrospettiva della mente. La memoria, il ricordo, l’evocazione, costituiscono un itinerario di indagine sulle cronologie, le stagioni della vita, i ricordi più significativi che si sviluppano nella didattica autobiografica con chiari scopi di carattere cognitivistico, dove il ricordare è produzione di racconto in una sorta di “teleologia retrospettiva” elaborata, secreta, suturata insieme da molteplici insegnamenti.
La riattivazione di abilità cognitive necessarie alla rimemorazione, conseguente al fare autobiografia, diviene rievocazione poetica, ricerca di significato, sviluppando un’intelligenza interiore e analitica che stimola un nuovo amore di sé.
Laura Tussi da da PeaceLink.it
Articoli correlati
 Coordinare la sicurezza nazionale tra politica interna ed estera, civile e militare
Coordinare la sicurezza nazionale tra politica interna ed estera, civile e militareIl nuovo paradigma della difesa: un continuum tra fisico e digitale
Pur rimanendo alto il livello della competizione fra colossi militari e aziende tech, le prime contando sulla potenza ed esperienza, le seconde sulla rapidità e innovazione, conviene per entrambe siglare accordi3 febbraio 2026 - Rossana De Simone- Schede di lettura semplificate
L’elenco dei programmi militari italiani della legislatura in corso
Ogni programma è preceduto dal numero dell'atto di governo. L'elenco è aggiornato alla data odierna. I programmi militari sono stati raggruppati per tipologia.3 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink  Comunicato stampa
Comunicato stampaIl Comune di Genova ha stanziato 5 milioni € per servizi Microsoft: 1800000 si potevano risparmiare
Come? Adottando il software libero LibreOffice al posto di Microsoft Office8 gennaio 2026 - Nicola Vallinoto Campagna per la libertà e la sovranità digitale europea
Campagna per la libertà e la sovranità digitale europeaBilancio del Comune di Genova: risparmiare un milione di euro ogni due anni con il software libero
Il Comune di Genova ha appena messo a bilancio oltre un milione e mezzo di euro solo per una licenza proprietaria ma potrebbe risparmiarne un milione ogni due anni se usasse software liberi9 dicembre 2025 - Nicola Vallinoto

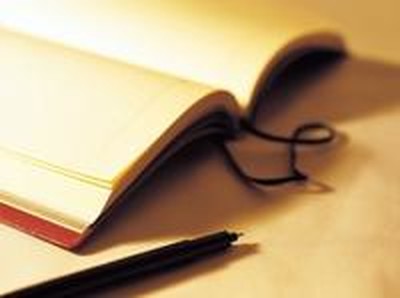
Sociale.network